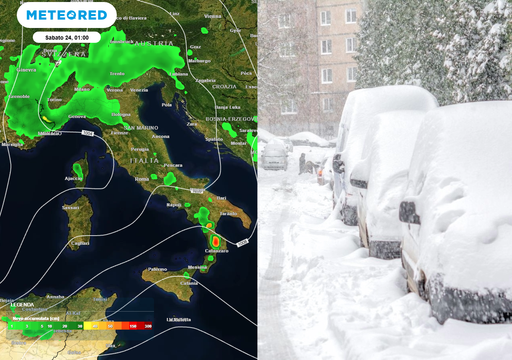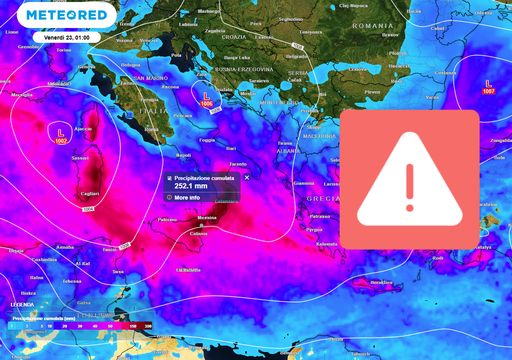Seveso 10 luglio 1976, la “Chernobyl d’Italia”: quando una tranquilla estate fu interrotta da un grave disastro chimico
Ripercorriamo la meteostoria e quel che successe il 10 luglio del 1976 a Seveso. Una nube di diossina sospinta da venti da nordovest contaminò alcuni comuni del milanese. Cosa successe quel giorno e come è oggi la situazione?

Nel mese di luglio 1976, la tranquilla estate azzorriana fu scossa da un grave incidente industriale con rilascio di una nube tossica carica di diossina. Successe il 10 luglio, fra Meda e Seveso, nell’hinterland milanese.
Nello stabilimento dell’ICMESA, una industria chimica un reattore andò fuori controllo durante la produzione di triclorofenolo, un ingrediente per erbicidi. Si sprigionò una nube contenente diossina TCDD (tetraclorodibenzodiossina), una delle sostanze chimiche più tossiche conosciute.
Un incidente che segnò anche uno spartiacque nella sensibilizzazione e legislazione ambientale, da cui nacque per esempio proprio la direttiva Seveso.
La situazione meteo di quel giorno
Il 10 luglio 1976 a Milano Linate la temperatura massima segnò 33°C, un giorno caldo per quei tempi, in tutto il mese il termometro non salì oltre i 34°C e ad agosto mai Milano toccò i 30°C.
In questo contesto meteo si sprigionò la nube di diossina, allora non erano disponibili questi importanti strumenti per la previsione di diffusione di inquinanti o nubi tossiche e passarono giorni prima che fossero presi provvedimenti.
L’incidente del 10 luglio 1976
Sabato 10 luglio 1976 alle 12:28 nello stabilimento ICMESA, situato nel comune di Meda al confine con Seveso, in un reattore chimico utilizzato per la produzione di triclorofenolo, si verificò un guasto al sistema di controllo che causò un aumento della temperatura e della pressione oltre i limiti di sicurezza.
Questo problema permise alla reazione, di natura esotermica, di continuare a sviluppare calore senza essere tenuta sotto controllo.
La temperatura nel reattore salì fino a 250 °C, ben oltre i 170 °C previsti per il processo. Ciò alterò la reazione chimica, provocando la formazione di una quantità anomala di diossina. L’aumento di pressione fece attivare il sistema di sfogo del reattore, fu evitata l’esplosione ma vi fu appunto il rilascio in atmosfera una nube tossica.
La diffusione della nube
Una nube visibile anche ad occhio nudo si diffuse spinta dai venti da nordovest, e si portò sui comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno, Limbiate e Desio. Il territorio più colpito fu quello di Seveso, il più vicino allo stabilimento e il più esposto ai venti.
Solo il 15 luglio arrivarono i primi provvedimenti, con ordinanze dei sindaci per proibire di toccare ortaggi, vegetazione, terreno e altri provvedimenti palliativi come raccomandare accurata igiene personale. Trascorsero 7 giorni dall’incidente prima che la notizia comparisse sui giornali.
Il 19 luglio la proprietà ammise la presenza di diossina nella nube tossica. L’area intorno all’ICMESA fu suddivisa in tre zone di contaminazione decrescente: A (la più colpita), B e R. La zona A fu evacuata su ordinanza dei Sindaci di Seveso e Meda.
#10luglio 1976
— Caritas Ambrosiana (@caritas_milano) July 9, 2018
Una nube di diossina fuoriesce dallo stabilimento chimico della Icmesa provocando una delle peggiori catastrofi ambientali di sempre: il Disastro di #Seveso pic.twitter.com/lqKZ6WXnEX
Conseguenze sanitarie e ambientali
Tra il 26 luglio e il 2 agosto furono evacuate 736 persone. La maggior parte rientrò tra ottobre e dicembre 1977, ma 41 famiglie non poterono tornare perché le loro abitazioni furono demolite. Circa 240 persone, soprattutto bambini, svilupparono gravi irritazioni cutanee causata dalla diossina. Complessivamente la contaminazione riguardò un’area abitata da circa 30.000 persone.
Gli effetti a lungo termine sulla popolazione sono oggetto di monitoraggio ancora oggi. Uno studio del 2011 su 97 uomini nati tra il 1977 e il 1984 ha rilevato che quelli allattati al seno da madri esposte alla diossina nella zona contaminata di Seveso presentavano quantità, concentrazione e mobilità dello sperma significativamente ridotte rispetto al gruppo di controllo.
Alcuni studi indicano un incremento di linfomi, leucemie e mielomi nelle zone più prossime all’ICMESA. Tra il 1977 e il 2012 si è osservato un eccesso di tumori al retto e al seno nelle zone A e B.
Una lezione che cambiò l’Italia e l’Europa
L’incidente di Seveso scosse l’opinione pubblica e costrinse la politica ad agire con le prime leggi ambientali e sulla sicurezza dagli incidenti industriali.
Nel 1982 arrivò dal Parlamento e dalla Comunità Europea la Direttiva Seveso, una normativa specifica per la prevenzione dei rischi industriali gravi. Seguirono due nuove direttive Seveso, nel 1996 e nel 2012.
Tuttavia non tutto è stato risolto, una parte di terreno contaminato non è stata asportata e i materiali furono sigillati in due grandi vasche impermeabilizzate, sopra cui oggi sorge proprio il Bosco delle Querce. Queste aree restano sotto monitoraggio continuo.
Seveso è diventata un simbolo di rinascita ambientale e memoria storica di quella che viene anche chiamata “La Chernobyl d’Italia” per l’impatto della tragedia e le lezioni apprese sulla sicurezza industriale e ambientale.