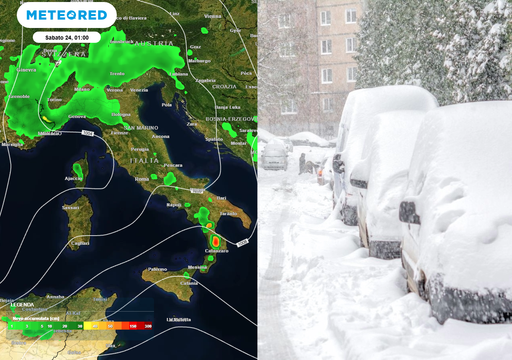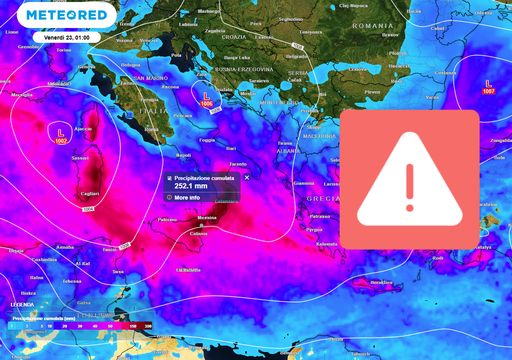L'uomo che si è lasciato mordere da 200 serpenti per creare l'antidoto di cui il mondo aveva bisogno
Per quasi due decenni, Tim Friede ha trasformato il suo corpo in un campo di battaglia: si lasciava mordere dai serpenti per costringere il suo corpo a produrre anticorpi. Oggi gli scienziati ritengono che il suo sangue possa essere una risorsa biologica inestimabile.

Molti lo hanno definito eccentrico, ossessivo o folle. Ma il nome di Tim Friede è destinato a entrare nella lista di chi ha messo a rischio la propria vita per la scienza.
Questo statunitense di 55 anni si è fatto mordere oltre 200 volte da alcuni dei serpenti più velenosi al mondo per consentire al proprio organismo di sviluppare anticorpi in grado di renderlo immune.
I risultati dei suoi esperimenti
Oggi, i suoi straordinari esperimenti –diventati popolari su YouTube– hanno acquisito un nuovo significato: gli scienziati hanno scoperto nel suo sangue anticorpi capaci di neutralizzare i veleni di numerose specie, un passo importante verso un possibile antidoto universale.

Attualmente, gli antidoti vengono prodotti iniettando veleno negli animali: gli anticorpi generati vengono poi estratti e somministrati all’uomo.
Tuttavia, ogni specie di serpente produce tossine diverse, anche all’interno della stessa area geografica, e per questo l’antidoto deve essere specifico e identificare rapidamente il tipo di serpente – un compito spesso difficile, costoso e non sempre possibile.
Secondo l’OMS, ogni anno oltre 110.000 persone muoiono a causa di morsi di serpente e più di 300.000 subiscono amputazioni o disabilità permanenti. Il sangue di Tim Friede rappresenta quindi una speranza concreta: il suo organismo ha sviluppato anticorpi in grado di neutralizzare un’ampia varietà di neurotossine letali. I risultati, pubblicati sulla rivista Cell, potrebbero aprire la strada a un antidoto ad ampio spettro.
Una vita segnata dai morsi
Friede ha iniziato i suoi esperimenti più di vent’anni fa nella sua casa in Wisconsin, spinto da curiosità scientifica e da un’esperienza personale: a cinque anni fu morso da un serpente, un evento che segnò la sua vita.
Lontano dall’aver sviluppato una fobia, si appassionò ai serpenti, collezionandone oltre 60 nel seminterrato. Imparò a estrarre il veleno e iniziò a iniettarselo, con l’obiettivo di raggiungere l’autoinmunizzazione.
Il percorso non è stato indolore: finì in coma per quattro giorni dopo il morso di due cobra e ha perso parte di un dito. “Non volevo morire, né perdere un dito o il lavoro”, raccontò alla BBC. Ma il suo obiettivo andava oltre: “È diventato uno stile di vita. Continuavo per tutte quelle persone lontane che muoiono ogni giorno per un morso”.

Come sperava, il suo sangue ha iniziato a contenere anticorpi rarissimi, capaci di riconoscere e neutralizzare diversi tipi di veleno. Mentre i suoi video si diffondevano online, la sua storia attirò l’attenzione del dottor Jacob Glanville, CEO della biotech Centivax.
“Se esiste qualcuno con anticorpi così ampiamente neutralizzanti, è lui”, dichiarò. E aggiunse: “Alla prima chiamata gli dissi: so che suona strano, ma vorrei un campione del tuo sangue”. Friede accettò subito.
Con Glanville e il professor Peter Kwong (Università di Columbia), il team ha identificato due anticorpi in grado di neutralizzare più classi di neurotossine. Combinandoli con un terzo elemento, hanno creato un cocktail che, nei test su topi, ha permesso di sopravvivere a dosi letali di veleno in 13 specie su 19. Nelle restanti sei, l’effetto è stato parziale ma promettente.

“Potrebbe coprire gran parte delle specie di elapidi, per le quali oggi non esiste antidoto”, spiega Glanville. Per Kwong, si tratta di “una protezione di ampiezza senza precedenti”. “Il sistema immunitario di Tim ha imparato a riconoscere un’ampia varietà di tossine”, ha aggiunto.
Lo studio si è concentrato sugli elapidi, una famiglia che include cobra, mamba, taipan, bungaro e serpenti corallo, accomunati da veleni neurotossici che paralizzano il sistema nervoso e possono bloccare la respirazione in pochi minuti.
Il segreto del suo sangue
Le tossine dei serpenti agiscono a diversi livelli: nervoso (neurotossine), ematico (emotossine) e cellulare (citotossine). Mentre gli anticorpi convenzionali agiscono su bersagli specifici, quelli di Friede riescono a identificare schemi comuni tra diverse tossine della stessa classe, candidandosi così come base per un antidoto universale.
Tim Friede has let deadly snakes bite him over 200 times. For more than two decades, hes been building immunity to help scientists create a universal antivenom.
— Complex (@Complex) 4 maggio 2025
Now, his blood is being used to develop a treatment that may protect people from a wide range of snakebites and save pic.twitter.com/6j96DiBABq
Se perfezionato, questo approccio potrebbe portare a un trattamento unico contro molte specie. I ricercatori stanno valutando l’aggiunta di un quarto elemento per garantire protezione completa. Il prossimo obiettivo sarà affrontare i viperidi, l’altra grande famiglia di serpenti velenosi, noti per i loro veleni emotossici.
I risultati sono promettenti, ma restano molti test da effettuare. “È una prova solida di fattibilità”, ha detto alla BBC il professor Nick Casewell della Scuola di Medicina Tropicale di Liverpool, “ma il cocktail necessita ancora di molte validazioni prima di poter essere usato sull’uomo”.
Per Friede, ne è valsa la pena. “Sto facendo qualcosa di buono per l’umanità, e per me era importante. Ne sono orgoglioso”, ha ammesso. Il suo consiglio però è chiaro: “Non fatelo a casa”. La sua storia non è un esempio da imitare, ma una straordinaria opportunità che la scienza ha saputo cogliere. E forse, grazie a lui, un giorno il veleno non sarà più una condanna.
Fonti della notizia:
Snake venom protection by a cocktail of varespladib and broadly neutralizing human antibodies. Cell, 2025. Jacob Glanville et al.